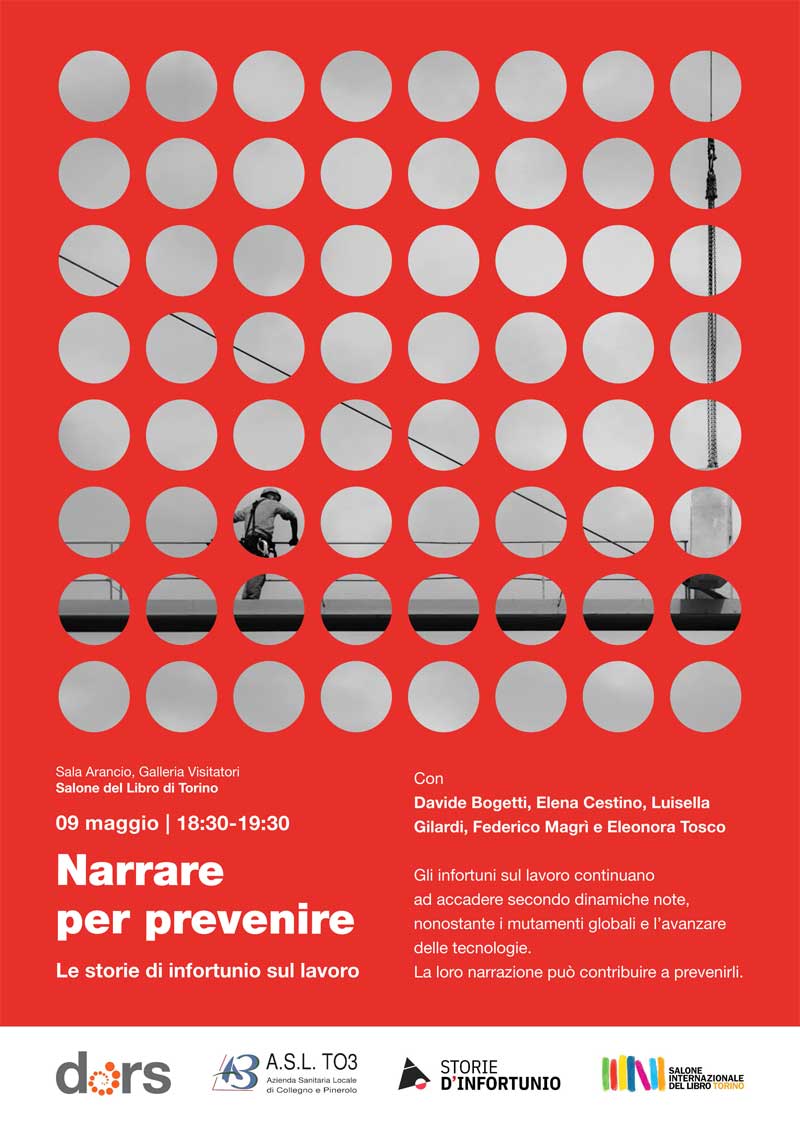L’attività fisica al lavoro fa bene alla salute?

a cura di: Angelo d’Errico
Mentre per l'attività fisica nel tempo libero (leisure time physical activity: LTPA) sono ormai dimostrati chiari effetti benefici sulla salute, tra cui una riduzione della mortalità e dell'incidenza delle malattie cardiovascolari (CVD), l'attività fisica sul lavoro (occupational physical activity: OPA) non parrebbe avere gli stessi effetti positivi, sulla base di molti studi recenti che hanno trovato piuttosto un aumento del rischio di mortalità e di malattie cardiovascolari o non hanno trovato alcuna associazione.
La discrepanza tra l'effetto potenzialmente dannoso dell'OPA sulla salute e quello benefico della LTPA è stata denominata “paradosso dell'attività fisica” e interpretata come dovuta alle differenze nelle caratteristiche dell'attività fisica nei due domini: rispetto alla LTPA, l'OPA comporterebbe in generale livelli di attività di intensità inferiore, per lo più incapaci di migliorare la forma cardiorespiratoria, ma sostenuti per tempi molto più lunghi, spesso con pause di recupero insufficienti (Holtermann et al. 2018).
Nonostante le crescenti evidenze sui possibili effetti negativi dell'OPA sulla salute, le ultime linee guida dell'OMS sull'attività fisica continuano a equiparare i benefici per la salute della LTPA a quelli dell'OPA, affermando che “ogni passo conta” per raggiungere la quantità di attività fisica raccomandata, indipendentemente dal fatto che venga svolta nel tempo libero o al lavoro (Bull et al., 2020). Secondo le linee guida dell'OMS, non ci sono prove sufficienti per distinguere tra gli effetti sulla salute dell'attività fisica in diversi ambiti.
Operatori del SEPI hanno voluto contribuire all'attuale dibattito sugli effetti dell'OPA sulla salute, valutando l'impatto dell'esposizione ad OPA sul rischio di mortalità per tutte le cause e sull'incidenza di CVD in tre grandi coorti, che sono tra i più grandi dataset longitudinali disponibili in Italia, con dati sulla mortalità e sulle ospedalizzazione per causa dei soggetti inclusi per molti anni. La prima comprendeva i partecipanti all’Indagine Multiscopo sulla Salute Istat del 2005, e le altre due erano costituite da soggetti residenti a Torino e partecipanti rispettivamente ai censimenti del 2001 e del 2011.
Sono stati selezionati solo soggetti occupati di età 25-60 anni. L'esposizione ad OPA è stata assegnata ai lavoratori dello studio attraverso una matrice occupazione-esposizione (JEM) costruita a partire dalla banca dati italiana O*NET, che contiene informazioni su centinaia di descrittori fisici e mentali, in termini di abilità, conoscenze, attività, contesto lavorativo, ecc., aggregati a livello di professione (796 professioni) (www.onetcenter.org). Dalle centinaia di variabili disponibili in O*NET, sono stati selezionati 17 fattori potenzialmente implicanti un elevato carico di lavoro fisico, i cui punteggi sono stati sommati per calcolare un indice composito di esposizione ergonomica (Ergo-index), che era la misura di esposizione ad OPA utilizzata nello studio. Lo studio ha riscontrato un aumento del rischio di mortalità associato all'esposizione ad alti livelli di OPA in tutte le coorti tra gli uomini e in due su tre tra le donne. Anche per quanto riguarda le CVD, sia gli uomini che le donne nel quartile di esposizione più alto presentavano un rischio significativamente più elevato.
I nostri risultati indicano che l'esposizione ad OPA non riduce il rischio di mortalità o di CVD, diversamente dalla LTPA, ma piuttosto supportano l'ipotesi del “paradosso dell'attività fisica”, secondo cui l’esposizione ad alti livelli di OPA può essere dannosa per la salute. Gli interventi preventivi sul posto di lavoro dovrebbero ridurre l'intensità dello sforzo fisico, limitando anche la durata del lavoro fisico sostenuto attraverso un aumento dei periodi di recupero.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica International Archives of Occupational and Environmental Health. Fontana D, Ceron R, d’Errico A. Occupational physical activity, all-cause mortality and incidence of cardiovascular diseases: results from three Italian cohorts. International Archives of Occupational and Environmental Health. 2023;97(1):81-100. doi:10.1007/s00420-023-02028-w
Per saperne di più
1. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med. 2020;54(24):1451-1462. doi: 10.1136/bjsports-2020-102955.
2. Holtermann A, Krause N, van der Beek AJ, Straker L. The physical activity paradox: six reasons why occupational physical activity (OPA) does not confer the cardiovascular health benefits that leisure time physical activity does. Br J Sports Med. 2018;52(3):149-150. doi: 10.1136/bjsports-2017-097965.

 22/09/2025 Bologna ore 14.30-17.30 Sapori e dissapori: il potere del cibo. Nelle prossime settimane maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione.
22/09/2025 Bologna ore 14.30-17.30 Sapori e dissapori: il potere del cibo. Nelle prossime settimane maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione.